Il terzo capitolo di Vita Activa. La condizione umana (Bompiani), pubblicato nel 1958 da Hannah Arendt, rappresenta una profonda ed attualissima riflessione sulla condizione umana nel rapporto con il lavoro, indagata attraverso una prospettiva che integra il pensiero di Heidegger e una rilettura critica di Marx (che potrebbe rappresentare un approfondimento piuttosto interessante in separata sede).
Nell’opera si mette in evidenza la categoria dell’Animal Laborans e Arendt descrive l’essere umano legato al ciclo vitale, dominato dalla necessità di soddisfare bisogni biologici.
Questa condizione colloca il lavoro nel regno della necessità, in contrasto con l’opera, che appartiene al dominio dell’artificio e della durabilità.
Arendt distingue chiaramente il lavoro dall’opera:
- Il Lavoro, prodotto dell’animal laborans, è un’attività necessaria e ciclica, destinata al consumo immediato e intrinsecamente legata alla sopravvivenza biologica. È marchiato dalla transitorietà e dalla fugacità.
- L’Opera, invece, è il prodotto dell’homo faber, il quale costruisce un mondo di oggetti durevoli che trascendono la vita biologica, costituendo la base del vivere comune.
Nella modernità, tuttavia, questa distinzione è sfumata, ovvero i prodotti dell’opera vengono confusi con quelli del lavoro, e il consumo prevale sull’uso.
L’animal laborans ha soppiantato l’homo faber, sancendo il trionfo della necessità sulla libertà e sulla stabilità del mondo umano.
Arendt critica in modo netto la centralità assunta dal lavoro nella società moderna, sottolineando come l’ascesa dell’animal laborans comporti conseguenze devastanti:
Alienazione dalla sfera politica: l’animal laborans, concentrato sul soddisfacimento dei propri bisogni, è intrinsecamente apolitico, incapace di partecipare alla creazione di una realtà condivisa. Cultura del consumo e della produzione di massa: la modernità promuove un’economia basata sul consumo incessante, che riduce ogni oggetto a una funzione effimera, minacciando la possibilità di costruire un mondo comune duraturo.
Automazione e alienazione: Sebbene la tecnologia sembri offrire una via d’uscita dalla fatica, essa intensifica il processo di alienazione, poiché non elimina la necessità legata alla corporeità; piuttosto, l’uomo diventa dipendente dalle macchine, perdendo non solo la fatica fisica, ma anche la capacità di pensare in modo autonomo.
La critica di Arendt si rivela straordinariamente attuale, in un mondo dominato dalla tecnologia e dall’economia dello spreco.
L’automatizzazione del lavoro non ha emancipato l’uomo, ma lo ha reso ancora più dipendente da un sistema che accelera i cicli di produzione e consumo, contribuendo alla distruzione dell’ambiente e riducendo la capacità dell’individuo di agire e pensare in modo autentico.
Arendt ci invita a riflettere sul significato del lavoro e della produzione nella società moderna, opponendosi alla logica che sacrifica la durabilità e la stabilità a favore di una produttività vorace. La sfida per l’uomo contemporaneo è ritrovare uno spazio per il pensiero, l’azione e la creazione di un mondo comune, emancipandosi dalla schiavitù delle necessità biologiche e della dipendenza tecnologica.
Dopo ormai un quarto di secolo dall’affascinante bivio dell’anno 2000, si è manifestata la proliferazione di teorie sul lavoro e sulle risorse umane, dimenticando spesso basi filosofiche come quella di Hannah Arendt, o di altri scienziati socio-antropologici che hanno messo in guardia dai sincretismi pericolosissimi che possono derivare dalla commistione generalista ed incontrollata di pensieri troppo eterogenei, assistendo ad un pericoloso melting-pot fra teorie economiche (finanziarie) e scienze umane.
Quando si parla di cultura d’impresa, spesso di tende a dimenticare che la stessa “cultura” può essere connotata da esigenze multiformi: una cultura di impresa può essere orientata ai risultati (obiettivi ed efficienza), può essere collaborativa (valorizzando il lavoro di squadra ed il supporto reciproco), oppure innovativa (promuovendo creatività, cambiamento e sperimentazione), o infine burocratica (con regole rigide e gerarchie).
E dove avviene la metamorfosi? Nei cambiamenti interni ed esterni, come ad esempio nell’approccio o l’ingresso nel mondo del lavoro di nuove generazioni (spesso disorientate da input incoerenti e privi di consistenza tangibile), nel progresso tecnologico (sempre più spesso orientato), nella mondializzazione (deriva perversa della globalizzazione) o, come purtroppo sperimentato, in una pandemia a livello planetario.
Offrire una visione distopica non è un esercizio di pessimismo: certo, nell’era dei social dove si tende a positivizzare il personale e a criticare pesantemente tutto ciò che è “altro”, un messaggio come questo, connotato da “pesante cautela preventiva” risulta sicuramente atipico, forse improprio, sicuramente anacronistico.
Si ritiene necessario tuttavia mettere in luce due fenomeni strettamente interconnessi, che evidenziano una crisi strutturale nella nostra società: la trascuratezza educativa e la soppressione delle piccole entità produttive e intellettuali. Entrambi questi aspetti minano la capacità della società di sostenere un futuro in cui la comunità, l’individuo e la creatività possano prosperare.
Michele Bernardi
Imprenditore Olivettiano, Sociologo ed Antropologo
Nato a Perugia, cittadino del mondo.
Cultore dell'osservazione partecipante, ho messo la sociologia Olivettiana al centro del mio quotidiano.
Nella mia attività professionale, legata alla sicurezza, pongo attenzione al mio territorio e al mio ambiente.
Amo la mia famiglia più di ogni altra cosa al mondo.
info@michelebernardi.com




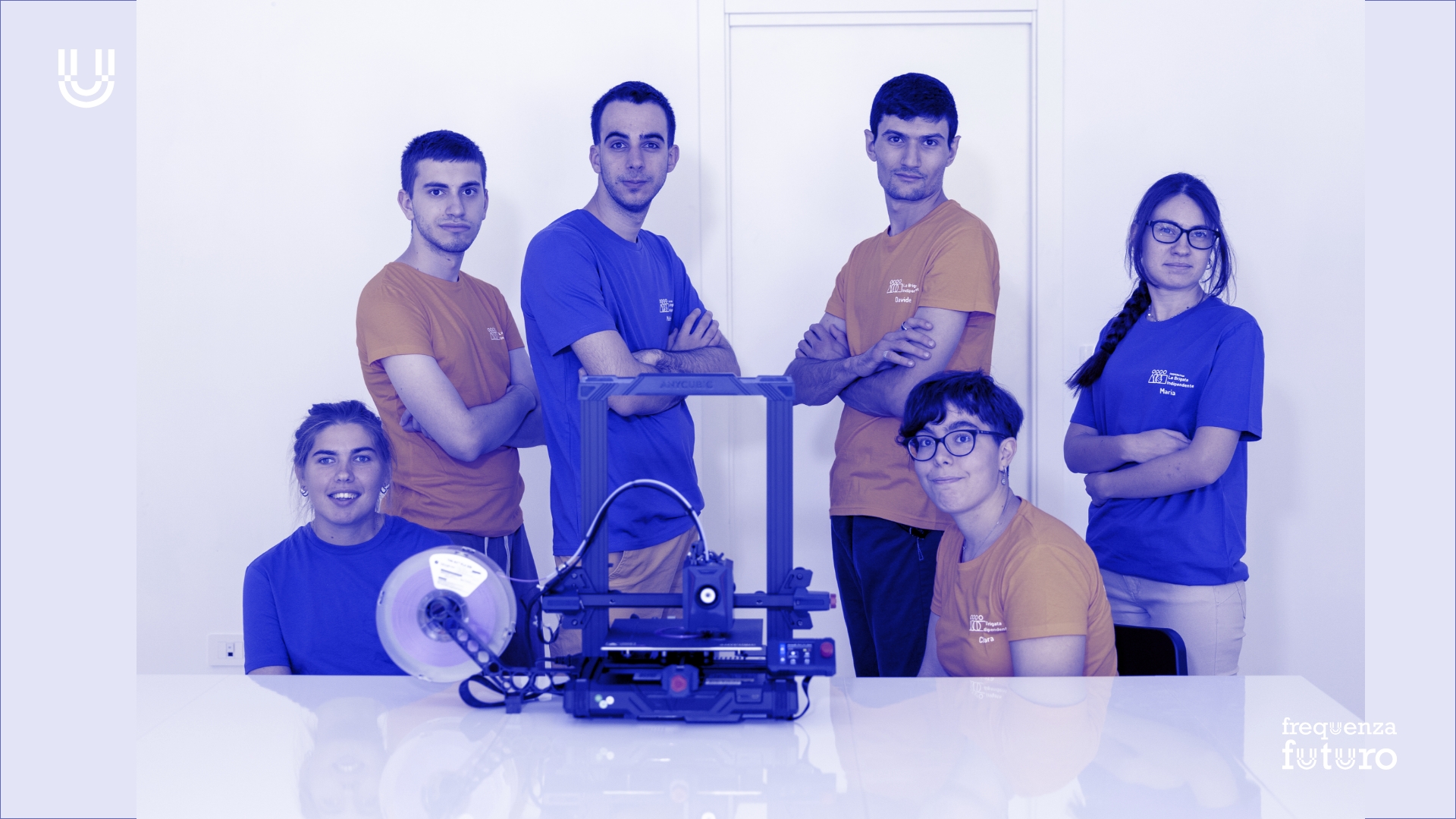
Una risposta
Sempre un passo avanti, complimenti Michele. Devo farlo leggere ai miei colleghi/titolare, ma non riusciranno mai a capire.