Ci sono parole ed espressioni che, a forza di essere ripetute, si logorano come monetine passate di mano in mano.
“Work-life balance”, per esempio, sembra ormai un dogma: da una parte il lavoro, gravato di doveri e costrizioni; dall’altra la vita, immacolata e inafferrabile, che inizia solo quando il badge scatta sull’uscita.
È un’idea talmente radicata che fatichiamo a immaginare alternative: eppure basta aprire a caso un libro di storia, o anche solo lasciare che la memoria collettiva faccia capolino, per accorgersi che la vicenda umana è stata plasmata da persone che nel lavoro hanno trovato, più che una prigione, la propria liberazione.
Primo quadro: Roma, inizio Cinquecento.
Michelangelo Buonarroti accetta, di malavoglia, l’incarico di affrescare la volta della Cappella Sistina.
Nelle sue lettere trapela tutto fuorché la gratitudine: si lamenta della postura innaturale, del calcinaccio che brucia gli occhi, dei muscoli induriti.
Eppure torna ogni mattina su quell’impalcatura, incurante della calce che gli spacca la pelle; nessuno lo costringe con catene; lo tiene lì un senso quasi feroce di necessità.
Nelle pause abbozza sonetti in cui maledice la propria sorte, ma poi riprende il pennello perché, in quell’abbraccio fra dolore e visione, intravede la possibilità di dare forma al divino: quando, quattro anni dopo, le impalcature vengono smontate, il volto di Adamo che sfiora la mano di Dio è già un’icona destinata ad attraversare i secoli.
Viene voglia di chiedersi: se Michelangelo avesse lavorato “solo il necessario”, risparmiandosi fatiche e crampi, ci ritroveremmo oggi, a mezzo millennio di distanza, con le lacrime agli occhi sotto quel cielo dipinto?
Cambiamo scena e passiamo a Ivrea, 1962.
L’Olivetti, che pochi anni prima aveva sognato mainframe europei, sembra arretrare dall’elettronica: i grandi calcolatori sono stati ceduti alla General Electric e il futuro s’intravvede a fatica.
Pier Giorgio Perotto, ingegnere dal tratto asciutto, rifiuta l’aria di resa che si respira nei corridoi, raduna quattro colleghi e si rifugia nei sotterranei di Borgolombardo.
Le porte restano accostate, i registri di laboratorio non riportano gli esperimenti notturni, qualche volta si lavora a lume di torcia per non attirare attenzioni: una vera carboneria hi-tech.
Il progetto è visionario – ridurre un calcolatore alla dimensione di una macchina da scrivere – ma i fondi scarseggiano, i componenti si recuperano smontando apparecchi dismessi.
Eppure, tra bobine di filo e caffè annerito, nasce la Programma 101; quando viene presentata alla Fiera Mondiale di New York nel 1964, la stampa ne coglie subito la portata: è la prima calcolatrice da tavolo programmabile.
Negli anni successivi NASA la userà per i calcoli delle missioni Apollo, la Banca d’Italia la adotterà nei centri contabili, scuole e università ne faranno un simbolo del possibile: se i «carbonari» di Ivrea avessero seguito il consiglio di «staccare la spina alle diciotto», la storia del personal computer avrebbe dovuto attendere altri pionieri, forse in un’altra latitudine.
Terzo quadro: Oxford, 1939.
L’Europa è sull’orlo della catastrofe bellica, i bilanci universitari soffrono, eppure il patologo australiano Howard Florey e il biochimico tedesco Ernst Chain decidono di riaprire un cassetto dimenticato.
Dentro c’è una coltura di Penicillium notatum, la muffa che Alexander Fleming aveva notato undici anni prima perché inibiva la crescita dei batteri: servono soldi, personale, apparecchiature; non c’è quasi nulla.
Gli scarti della mensa diventano terreno di coltura, vecchie bottiglie di latte fungono da fermentatori, i ricercatori dormono su brande accanto ai banconi, pronti a intervenire a qualsiasi ora nella delicata fase di estrazione.
Nel 1941 la penicillina è pronta per il primo uso clinico massiccio: durante la guerra ridurrà la mortalità per infezioni in modo tanto drastico da risultare, agli occhi dei chirurghi da campo, quasi miracolosa.
Se Florey e Chain avessero preferito “non portarsi il lavoro a casa”, saremmo entrati nell’era degli antibiotici con decenni di ritardo – chissà quanti milioni di vite in meno.
Tre storie, un’unica trama: la fatica, temperata da un orientamento di senso, diventa libertà concentrata.
Non è la libertà di oziare – preziosa anch’essa, ma incompleta – bensì l’ebbrezza di trasformare il mondo: un soffitto che racconta la Genesi, un calcolatore che anticipa la rivoluzione digitale, un farmaco che cambia la prognosi di un’epoca.
La psicologia contemporanea ci spiega perché queste vicende parlino così forte.
La Self-Determination Theory individua in autonomia, competenza e relazione sociale le tre molle della motivazione profonda; Mihály Csíkszentmihályi chiama flow quello stato di grazia in cui le sfide e le proprie abilità si bilanciano, al punto da far perdere la percezione del tempo.
In altre parole, quando lavoriamo in un contesto che ci lascia libertà di manovra, ci fa vedere l’impatto reale del gesto e ci offre appartenenza, la fatica non si contrae, si sublima.
Ecco perché il dibattito sulla “settimana corta” rischia di mancare il bersaglio se si limita al conteggio delle ore.
Ridurre la giornata di lavoro ha senso – e molto – se è il frutto di processi più snelli, di riunioni meno vuote, di tecnologia che cancella i compiti ripetitivi.
Ma se l’orario compresso convive con organizzazioni che continuano a togliere autonomia, che misurano il valore solo in KPI a breve, che non mostrano l’impronta sociale di un progetto, il beneficio evapora in fretta: avremo guadagnato un pomeriggio libero, perdendo però la possibilità di sperimentare il lavoro come spazio di significato.
Rimettere in circolo le storie di Michelangelo, dei “carbonari” della P101, dei pionieri della penicillina non è nostalgismo; è pedagogia civile.
Serve a ricordarci che la linea di demarcazione tra schiavitù e opera non coincide con il timbro del cartellino ma con il margine di senso che riusciamo a scavare.
Se il lunedì appare soffocante è anche perché abbiamo smesso di chiedere – a noi stessi oltre che alle organizzazioni – che cosa vogliamo davvero costruire; e quando il lavoro non costruisce, consuma: consuma tempo, energie, perfino identità, costringendoci poi a comprare svaghi sempre più costosi per anestetizzare la frustrazione.
L’alternativa non è abolire il lavoro inseguendo chimeriche rendite universali, né idolatrare un’iperproduttività che macina salute e relazioni.
L’alternativa è rendere le otto ore (o quante siano) territorio di progettualità: piccole squadre con vera responsabilità di risultato; trasparenza sull’effetto sociale o ambientale di ogni task; percorsi di apprendimento che misurino la crescita di competenza, non l’ansia da performance.
E fuori dall’orario? Serve tempo libero, certo, ma non come annegamento della mente nella distrazione: piuttosto come spazio di coltivazione – lettura, cittadinanza attiva, hobby che chiedono maestria e restituiranno energia fresca al giorno dopo.
Finché continueremo a contrapporre fatica e libertà, avremo calendarizzato la frustrazione: dal suono della sveglia al brindisi del venerdì.
Ma se torneremo a considerare il lavoro una palestra di potenza umana – non perché sia facile, bensì perché è nostro –, allora la linea fra orario e vita si sbiadirà e potremo scoprire, come sotto la volta dipinta o in un seminterrato di Ivrea o in un laboratorio improvvisato di Oxford, che il gesto laborioso, quando è abitato da senso, non restringe la vita: la dischiude.
Michele Bernardi
Imprenditore Olivettiano, Sociologo ed Antropologo
Nato a Perugia, cittadino del mondo.
Cultore dell'osservazione partecipante, ho messo la sociologia Olivettiana al centro del mio quotidiano.
Nella mia attività professionale, legata alla sicurezza, pongo attenzione al mio territorio e al mio ambiente.
Amo la mia famiglia più di ogni altra cosa al mondo.
info@michelebernardi.com


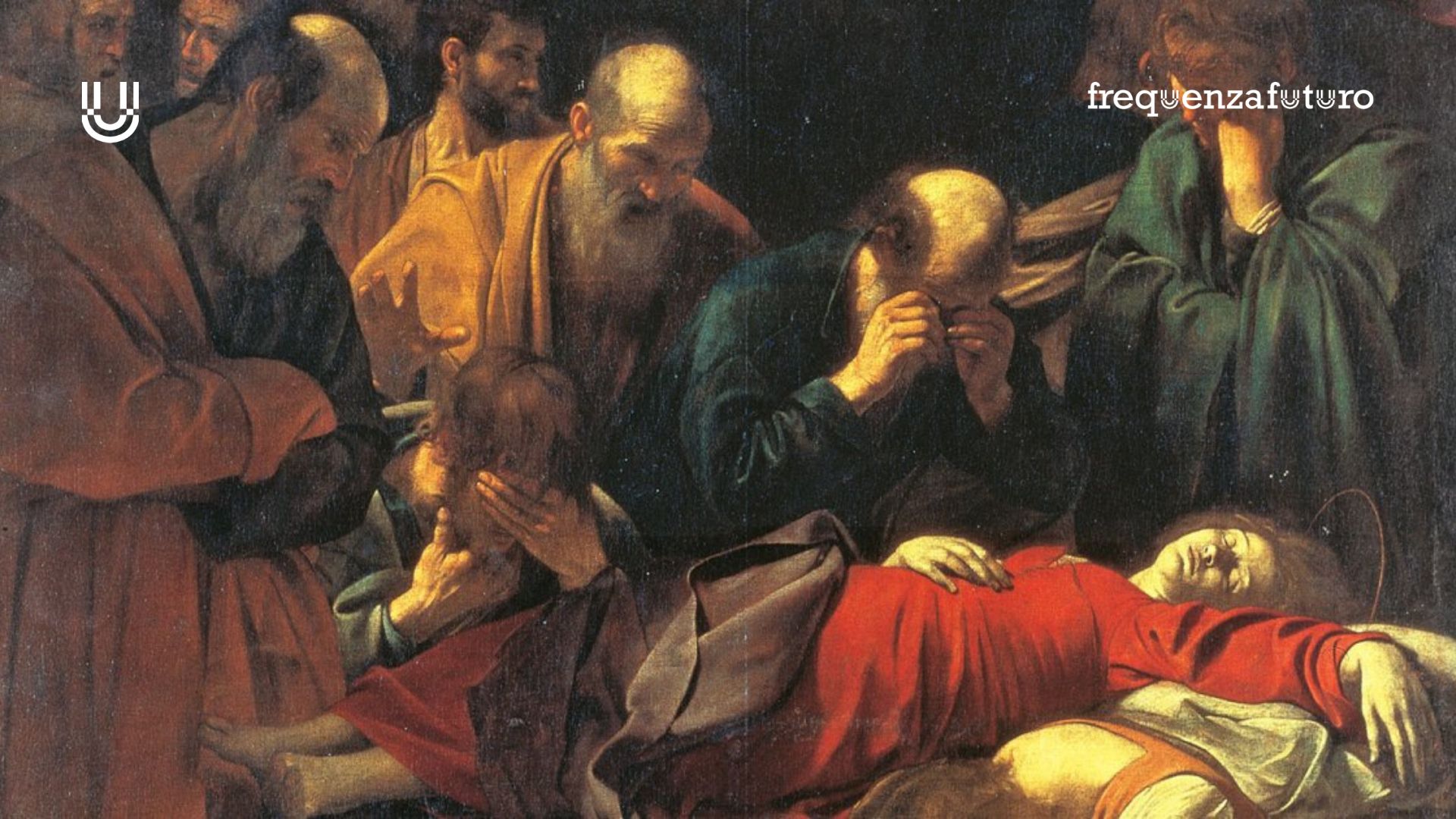


Una risposta
Molto attuale e significativo!